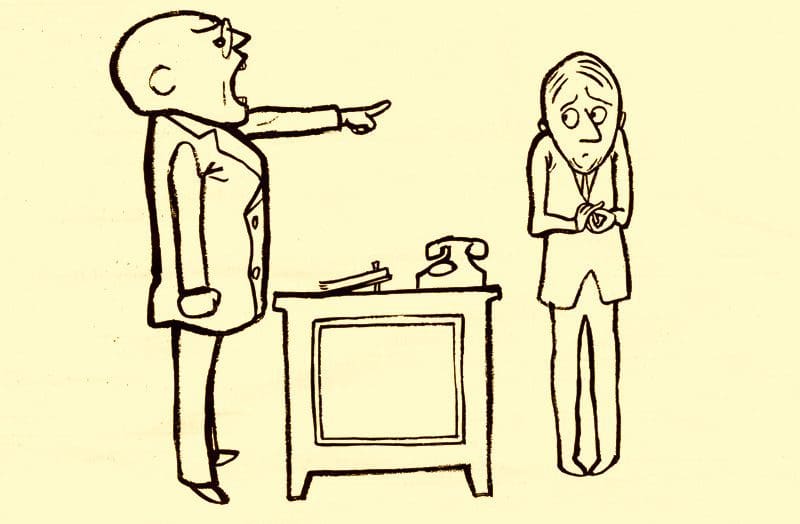La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 30606 del 2017 ha stabilito un importante principio in tema di potere disciplinare, precisando che il suo esercizio da parte del datore di lavoro deve rispettare limiti ben precisi per evitare comportamenti che possano integrare la fattispecie del mobbing.
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta con lo speciale pubblicato oggi (22.2.2018) dal Sole 24 Ore (Firma: M. Lambrou; Titolo: “Se la sanzione diventa mobbing” e “Danno esistenziale solo se cambiano le condizioni di vita”) che di seguito riportiamo.
Ecco l’articolo.
L’esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro deve rispettare limiti ben precisi, per evitare comportamenti che possano sconfinare nel mobbing, risultando passibili di condanne al risarcimento dei danni al lavoratore. La Cassazione, nella sentenza 30606 del 2017, ha stabilito ad esempio che l’esercizio del potere disciplinare, se abusivo e strumentale all’estromissione del dipendente dall’azienda, è idoneo a integrare la fattispecie del mobbing. In altri casi, i giudici hanno invece chiarito che l’esercizio, anche se scorretto e abnorme del potere disciplinare non integra di per sé il mobbing.
Appare utile, dunque, verificare la sussistenza e l’effettiva entità del rischio, per il datore, di incorrere in lesioni dei diritti del lavoratore nell’irrogazione dei provvedimenti. Quali sono, in altri termini, le caratteristiche di un’effettiva condotta mobbizzante?
Con l’espressione “mobbing” la giurisprudenza, nel silenzio della legge, si riferisce alle condotte che risultino vessatorie, aggressive e persecutorie nei confronti del dipendente. Ciò detto, si osserva come, a favore dell’azienda, giochi un ruolo fondamentale la ripartizione dell’onere probatorio. Spetta infatti al lavoratore dimostrare la totalità degli elementi costitutivi di questa fattispecie e, in particolare, del danno psicofisico patito. Il lavoratore è poi chiamato alla dimostrazione di un generale intento persecutorio, ossia di uno specifico “disegno” del datore mirato alla sua emarginazione. A ben vedere, si tratta di una prova assai difficile, la cui complessità parrebbe idonea a mettere al riparo il datore da condanne fondate su fattori presuntivi.
Tuttavia, pur nella gravosità di ricondurre differenti comportamenti a un unico intento lesivo, il datore è comunque chiamato a dotarsi di particolari cautele nell’irrogazione delle sanzioni. Nonostante la legittimità o meno del singolo provvedimento non venga in rilievo di per sé per configurare una condotta vessatoria, l’accertamento del giudice risulta particolarmente ancorato al dato fattuale, con una valutazione caso per caso delle contestazioni. Ove le sanzioni comminate si riferiscano, quindi, a episodi dotati di serietà, ciò potrebbe risultare sufficiente a escludere, da un lato, la pretestuosità del comportamento datoriale e, con ciò, gli estremi del mobbing.
In ogni caso, quand’anche fosse riscontrabile una tangibile abusività dell’esercizio del potere disciplinare, questa potrebbe, in ogni caso, mancare dei presupposti del comportamento mobbizzante.
In soccorso del datore viene, per di più, la necessaria sussistenza di ulteriori atteggiamenti pregiudizievoli. La giurisprudenza ha infatti negato che il mero abuso del potere disciplinare possa integrare autonomamente il mobbing, essendo indispensabile che altri e gravi comportamenti censurabili si accompagnino a questo. Cosicché la Cassazione, nel caso sopra richiamato, ha ritenuto opportuno condannare l’azienda che, oltre a comminare irregolarmente diversi provvedimenti, si era resa protagonista di ulteriori azioni mirate all’isolamento del dipendente, come lo spostamento ingiustificato di reparto.
L’esercizio del potere direttivo può ritenersi scevro da condanne, se limitato a richiami di natura verbale, come recentemente affermato dal Tribunale di Milano (sentenza del 26 giugno 2017).
Il datore che, nell’intimare sanzioni conservative, ha premura di considerare l’aspetto temporale, può dirsi, ancora una volta, immune da censure. Infatti, l’arco di tempo “sospetto” risulta assai ridotto e l’inusitata frequenza delle intimazioni permette di arrivare alla negazione di una responsabilità risarcitoria (Cassazione, sentenza 28098 del 2017). A livello meramente indicativo, il datore dovrebbe astenersi dall’irrogare provvedimenti per più di una volta al mese nell’arco di un semestre (Tribunale di Milano, sentenza del 5 luglio 2017), scongiurando con ciò la condizione indispensabile – la cui prova, ancora una volta, spetta al dipendente – della sistematicità delle condotte persecutorie.LE PRONUNCE
MOBBING, DA PROVARE CONDOTTE SISTEMATICHE
Il potere disciplinare del datore di lavoro, quando consiste nell’invio di contestazioni e nell’irrogazione di sanzioni di tipo conservativo, necessita, perché sia configurabile la fattispecie del cosiddetto mobbing, del carattere della sistematicità. Ove tale potere sia esercitato in episodi distaccati da un apprezzabile lasso di tempo e, quindi, con inusitata frequenza, va escluso l’intento persecutorio del datore.
Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 28098 del 24 novembre 2017SEMPRE RICHIESTO L’INTENTO PERSECUTORIO
Perché si abbia mobbing, le iniziative disciplinari devono essere strumentalmente preordinate a un disegno persecutorio, ovvero evidenziare chiaramente un abuso di potere del datore. Perché l’ipotesi considerata possa ricorrere, le condotte ostili, ancorché pretestuose, devono verificarsi almeno alcune volte al mese, il conflitto deve avere una durata di almeno sei mesi e bisogna dimostrare l’esistenza di una strategia di attacco mirato nei confronti del lavoratore.
Tribunale di Milano, sezione lavoro, sentenza del 5 luglio 2017RISARCIMENTO, UNA SOLA CONTESTAZIONE NON BASTA
Per il risarcimento, il ricorrente deve dare conto di ogni singolo atto o provvedimento del datore che, esaminato congiuntamente agli altri, possa essere qualificato come mobbing. L’invio di un’unica contestazione disciplinare in un rapporto lavorativo durato più anni, anche se infondata, non integra una condotta vessatoria. Il richiamo del superiore gerarchico non può ritenersi rilevante e consta in un ordinario esercizio del potere di controllo e organizzativo.
Tribunale di Milano, sezione lavoro, sentenza del 26 giugno 2017NON SONO AMMISSIBILI AZIONI UMILIANTI
Se il datore di lavoro si rende protagonista di condotte mortificanti e umilianti, durante l’esecuzione della prestazione lavorativa del dipendente, questi atteggiamenti devono ritenersi estranei al fisiologico esercizio del potere disciplinare di richiamare e correggere il lavoratore e, come tali, potenzialmente idonei a integrare mobbing. Ciò vale a prescindere dalla circostanza per la quale il lavoratore non abbia eseguito la propria prestazione a regola d’arte o negligentemente.
Tribunale di Mantova, sezione lavoro, sentenza del 25 maggio 2017STOP ALLA MINACCIA DI SANZIONI DISCIPLINARI
A parziale dimostrazione della condotta vessatoria del datore di lavoro nei confronti del dipendente, vengono in rilievo anche le prospettazioni intimidatorie di sanzioni disciplinari. Queste possono rivelarsi idonee a palesare la sussistenza di un contesto lavorativo ostile e avversivo – volto a isolare il lavoratore – e connotano, insieme ad altri elementi, un esercizio esasperato ed eccessivo, tra gli altri, del potere di controllo.
Corte d’appello di Catanzaro, sezione lavoro, sentenza del 5 maggio 2017DEVE ESSERE PROVATO L’ELEMENTO SOGGETTIVO
L’esercizio, ancorché scorretto e abnorme, del potere disciplinare non integra di per sé mobbing. Deve essere in ogni caso dimostrato l’intento persecutorio del datore, cosicché, quand’anche le iniziative sanzionatorie illegittime siano state assunte nel breve lasso di tempo di due mesi, in assenza della prova dell’elemento soggettivo, questo non basta ad affermare la configurabilità in termini di mobbing della condotta datoriale.
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3256 del 18 febbraio 2015
Danno esistenziale solo se cambiano le condizioni di vita
Se il lavoratore riesce a dimostrare che l’esercizio del potere disciplinare del datore è stato abusivo e strumentale alla sua estromissione dall’azienda, la condotta tenuta dal datore di lavoro può comportare conseguenze sul piano civilistico e, in determinati casi, rilevare dal punto di vista penale.
Sul piano civilistico, le vessazioni sul luogo di lavoro possono dare luogo a una responsabilità contrattuale del datore, ex articolo 2087 del Codice civile, per tutti i danni connessi all’attività prevista dal contratto di lavoro.
Il lavoratore che agisca in giudizio per il risarcimento dei danni da mobbing, tuttavia, deve dimostrare la presenza di una pluralità di elementi costitutivi, quali la molteplicità e globalità dei comportamenti a carattere persecutorio, l’esistenza del danno, l’intento persecutorio, e la relazione causale fra la condotta e il pregiudizio alla sua integrità (Tar Abruzzo L’Aquila, 9 maggio 2017, sentenza 201; Cassazione, sentenza 2326/2016). Il datore di lavoro è invece tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Qualora il lavoratore assolva gli oneri probatori a suo carico, il datore può essere chiamato a risarcire i danni non patrimoniali ex articolo 2059 del Codice civile e, secondariamente, i danni patrimoniali.
Tra i danni non patrimoniali rientrano:
il danno biologico, subordinato alla sussistenza di una lesione dell’integrità psico- fisica medicalmente accertabile;
il danno morale, quale turbamento dello stato d’animo;
il danno esistenziale, consistente nella significativa alterazione della vita quotidiana.
Tuttavia, il danno esistenziale non può riconoscersi sulla base di formule standardizzate o di generiche affermazioni, né in maniera automatica. È necessario, infatti, che il danneggiato alleghi tutte le circostanze volte a comprovare l’effettiva alterazione delle abitudini e condizioni di vita personale, non essendo sufficiente la mera potenzialità lesiva della condotta mobbizzante.
L’onere di precisa allegazione a carico del lavoratore sussiste anche rispetto al risarcimento dei danni patrimoniali, che consistono in una perdita economica, quali le spese sostenute per curarsi, il danno da mancata assunzione o promozione, il danno alla professionalità, il danno da perdita di chance. Inoltre, le condotte persecutorie potrebbero avere rilevanza penale, se integrano gli estremi di determinati reati, come, per esempio: lesioni personali (articolo 590 del Codice penale), minaccia (articolo 612), violenza privata (articolo 610) e infine, anche se è un ipotesi residuale, il reato di maltrattamenti in famiglia (articolo 572), che tuttavia si configura solo nel caso in cui, per le ridotte dimensioni dell’impresa e per la qualità delle relazioni tra il datore di lavoro e i lavoratori, tali rapporti possano essere intesi come “parafamiliari” e assimilarsi a quelli esistenti tra i componenti di una vera e propria famiglia (Cassazione, sentenza 13088 del 2014).
In ogni caso, il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere penalmente solo nel caso in cui ricorrano tutti gli elementi costitutivi del reato.