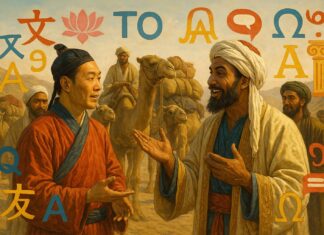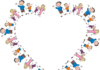La Cassazione stabilisce che anche i comportamenti fuori dall’orario di lavoro possono giustificare il licenziamento: ecco cosa cambia per dipendenti e aziende
Una recente sentenza della Cassazione ha cambiato le carte in regola su ciò che riguarda i licenziamenti. La questione ha sollevato una domanda con la relativa risposta che lascia al primo impatto, perplessi. Può un comportamento avvenuto lontano dall’ufficio, magari durante le vacanze o nel tempo libero, costare il posto di lavoro? Fino a poco tempo fa, molti avrebbero risposto di no. Oggi si rischia di avere conseguenze pesanti per migliaia di lavoratori: l’integrità morale del dipendente è un requisito fondamentale anche al di fuori dell’orario di servizio.
Il caso che ha portato a questa rivoluzione giuridica è clamoroso: un lavoratore è stato licenziato dopo essere stato coinvolto in episodi legati al mondo ultras, completamente estranei al suo ambiente professionale. Nonostante si trattasse di attività svolte nel tempo libero, la sua condanna penale ha avuto un impatto diretto sul contratto di lavoro. L’azienda ha ritenuto che un comportamento del genere minasse in modo irreparabile il rapporto di fiducia. E la Cassazione, con la sentenza n. 24100/2025, ha dato pienamente ragione al datore di lavoro.
Si tratta di una decisione che apre scenari nuovi e preoccupanti: non basta più fare bene il proprio lavoro, ma bisogna anche mantenere una condotta irreprensibile nella vita privata. Questo significa che un comportamento scorretto o penalmente rilevante, anche se commesso fuori dall’orario di lavoro, può mettere a rischio la stabilità occupazionale.
Quando la vita privata influisce sul lavoro
Il principio stabilito dalla Cassazione non ammette scuse: alcuni comportamenti extralavorativi possono compromettere la credibilità di un dipendente. In particolare, se si tratta di azioni gravi, capaci di minare l’immagine personale o di ledere istituzioni pubbliche e autorità, l’azienda ha il diritto di rescindere il contratto. Non si parla più solo di tutelare l’immagine aziendale, ma di proteggere quel legame fiduciario che costituisce la base di ogni rapporto professionale.

La Corte ha sottolineato che la gravità degli atti va valutata anche in base alle persone coinvolte e al contesto. In questo caso specifico, le aggressioni legate al mondo ultras hanno avuto come destinatari rappresentanti dello Stato e forze dell’ordine, rendendo la condotta incompatibile con il ruolo di lavoratore subordinato.
Un altro elemento importante emerso dalla sentenza riguarda la strategia dell’azienda. Il dipendente aveva sostenuto che i fatti erano noti da tempo e che quindi il licenziamento fosse tardivo. Ma i giudici hanno chiarito che il datore di lavoro può attendere la conclusione di un procedimento penale prima di agire. Non deve muoversi sulla base di voci o sospetti: solo la condanna definitiva legittima l’interruzione del rapporto.
Questa interpretazione rafforza il potere delle aziende, che possono valutare con calma la situazione, senza il rischio di subire ricorsi per licenziamenti frettolosi. Nel caso in esame, la mancanza di trasparenza del lavoratore – che non aveva informato il datore di lavoro della propria vicenda giudiziaria – ha aggravato ulteriormente la sua posizione.
Il dipendente aveva tentato un’ultima difesa, sostenendo di essere stato trattato diversamente rispetto ad altri colleghi. Ma la Cassazione ha ribadito che per dimostrare una discriminazione serve un confronto perfetto con situazioni identiche: stessi fatti, stesso contesto, stesse conseguenze. Un obiettivo quasi impossibile da raggiungere.